La frontiera in questione è il confine, fisicamente identificabile con il corso del fiume Rio Grande/Rio Bravo che dalla fonte, nel Colorado, alla foce, nel Golfo del Messico, separa il Sud-Ovest degli Stati Uniti dal Messico. Questa lacerazione incarnata nei muri, fili spinati e controlli della migra (polizia di frontiera) viene chiamata la ferita aperta i cui orli appartengono ad uno stesso territorio, un tempo Messico, e in tempi pre-colombiani chiamato Aztlán. L’incisione risale al 2 febbraio 1848, quando a Guadalupe Hidalgo venne stipulato il trattato che sanciva i nuovi confini degli Stati Uniti che per anni aveva condotto una guerra col Messico al fine di espandere la propria frontiera verso Sud-Ovest, annettendo territori messicani, nello specifico gli stati oggi conosciuti come Colorado, Texas, Nuovo Messico, Arizona, California. Questa ferita disegnata dal trattato e chiamata, come tutto quello che è nominato in quest’area, in duplice lingua, spagnolo e inglese, herida e wound, disegnò un’area culturalmente già molto complessa. La cultura india era comunque in parte sopravvissuta nella colonizzazione spagnola, mescolandosi, oltre che alla cultura europea, a quella degli schiavi africani e divenendo un laboratorio d’incessante transizione culturale, fino a quando gli angli assoggettarono quelle terre imponendo la propria lingua, oltre che la propria cultura, politica ed economia. Il caso dei chicanos, come si chiamano i messicani americani, è un caso a se stante nella storia culturale degli Stati Uniti: all’epoca dell’annessione, essi furono dichiarati cittadini statunitensi, ma vissero questa cittadinanza come violazione; fu richiesto loro di parlare inglese, ma un popolo che aveva già subito il furto della lingua con la colonizzazione spagnola e si era creato una lingua, il messicano, che aveva caratteristiche diverse dal castigliano del colonizzatore, non intendeva farsi derubare nuovamente della lingua. La resistenza al colonialismo linguistico, unica nel panorama delle culture che formano il variegato mosaico della cultura americana, derivava anche dalla consapevolezza che la terra su cui risiedevano era di diritto la loro, ereditata da civiltà antiche e composite. Inoltre, ancor prima degli insediamenti spagnoli, queste terre avevano visto continue migrazioni, popoli in movimento e lingue in movimento: dalle varie lingue amerinde si passò allo spagnolo che nei vari transiti diviene caló o pachuco (una forma di slang), spanglish (spagnolo-inglese), tex-mex e altre varianti ibride. I chicanos sostengono che queste terre non furono governate dagli Aztechi, ma da culture che gli odierni studiosi chiamano cultura nativa altra o, come Alicia Gaspar de Alba, alter-nativa (Gaspar de Alba 1997, 2002), contemporaneamente aliena e indigena in quel tratto di terra chiamato Ovest, idealmente sentendosi abitanti di una nazione mitica chiamata Aztlán, la patria, o el otro Mexico, il cui popolo viene chiamato raza. La razza di cui si parla fa riferimento non al sangue, alla biologia, ma alla cultura – che qui non si è mai presentata come uniforme e monologica – ovvero alla secolare mezcla o creolità che connota i soggetti che abitano il Sudamerica.
Uno dei primi ad usare il termine raza fu il filosofo messicano José Vasconcelos che descrisse “una raza mestiza, una mescolanza di razze affini, una razza di colore – la prima razza sintesi del globo” (Anzaldúa 1987, p. 119). Chiamata anche la raza cósmica, o quinta razza, abbracciava tutte le razze. Nella terminologia del border crossing, raza in ultima istanza si riferisce alla popolazione etnicamente e culturalmente mista che abita i territori del Sud-Ovest degli Stati Uniti, e spesso è termine interscambiabile con chicano. Questa raza o comunità chicana è segnata dall’attraversamento (crossing): la geografia culturale di questo spazio di frontiera è quanto mai varia, così come vari erano i popoli indi nativi che abitavano quegli spazi. Questa collusione-incontro di lingue e culture, questa storia di aggressione-invasione e risoluzione nell’ibridismo culturale e nella mezcla, questa necessità di continuamente riaggiustarsi a nuovi eventi, nuovi flussi e nuove colonizzazioni fanno delle borderlands, le terre di confine, un laboratorio di conflitto e convivenza. Con i movimenti radicali degli anni Sessanta e Settanta, soprattutto dopo la storica marcia del 1966 guidata da César Chávez da Delano a Sacramento per protestare contro la violazione dei diritti umani e civili dei filippini, messicani e chicanos, questi ultimi, immessi nell’esperienza epocale del passaggio dal consenso alla diversità, giunsero ad elaborare una teoria della frontiera come figura per dire del loro essere in mezzo. Ma fu nell’opera di Gloria Anzaldúa, borderlands/la frontera che prese corpo un'immagine-teoria-pratica della frontiera sì come “ferita aperta dove il terzo mondo si scontra con il primo e sanguina”, ma anche come luogo di confluenze dove può nascere “un terzo paese – una cultura di confine” (Anzaldúa 1987, p. 29). La storia di questa gente che ha sempre vissuto attraversando frontiere o attraversata da frontiere imposte, che è stata in perenne movimento seguendo le richieste della fame (come ancora oggi accade per i clandestini messicani che sfidano i controlli, o sfuggono agli strangolamenti della politica e dell’economia), ha di necessità portato alla nominazione/elezione di una condizione culturale di frontera/borderlands, e dei suoi affini e derivati: i confini, gli orli, le zone di contatto, i ponti, le soglie, i passaggi. Si tratta come luogo in cui posizionarsi, secondo le teorie e pratiche della location, così come è stata rivisitata da Caren Kaplan, che postula affiliazioni transnazionali fra donne che riescono a decostruire la propria cultura giungendo a vedere la propria casa-cultura con occhi-coscienza da outsider, da migrante e quindi in grado di cogliere la propria complicità nei meccanismi nazionalistici che giocano su interno/esterno, affiliato/estraneo (Kaplan, Grewal 1994). Questa consapevolezza permette di sviluppare prospettive multiple, letture del sé e dell’altro che mettono in crisi i concetti psico-sociali di identità fisse, autenticità, ma anche concetti culturali binari di margine e centro, identità e differenza, insider e outsider. Posizionandosi in-between – terminologia più tardi ripresa da Homi Bhabha – o in una posizionalità mestiza, per dirla con Anzaldúa, ciascun soggetto è contemporaneamente fuori e dentro il margine e, vedendosi con gli occhi dell’altro, è altro a se stesso e può quindi smettere di vedere l’altro come estraneo. Una volta decostruito il concetto di frontiera come linea divisoria, muraglia che incarna il divieto d’ingresso per i clandestini (chiamati bilinguisticamente mojados/wetbacks), come barriera, simbolo dell’oppressione del primo mondo; una volta fuoriusciti dalla contrapposizione assimilati/assimilatori o invasori, il confronto culturale crea una percezione dei soggetti come attraversatori, un popolo di fronterizos che può con-vivere come con-finante, come soggetto non neutramemente post-moderno ma oltre ogni post: in costante attraversamento di frontiere fisiche, psichiche, culturali. Si supera così la differenza razziale, la posizione antagonista che inchioda al duello oppressore/oppresso, dominatore/dominato e, assumendo una coscienza mestiza, ci si presenta come progenie ibrida, una specie mutevole. E da questa impollinazione razzialmente, ideologicamente, culturalmente e biologicamente incrociata scaturisce oggi una coscienza aliena, una nuova coscienza mestiza (Anzaldúa 1987): la coscienza delle borderlands, terre di confine. Come Amerigo Paredes sottolineava già nel 1978, la produzione culturale nata da questo contatto interetnico è molto più segnata dalla pratica-esperienza di border crossing presso la comunità messicana che presso quella anglo, perché, sostiene Paredes, a causa della posizione subalterna del chicano nell’ordine sociale di quell’area, i soggetti messicani fanno esperienza degli angli, mentre questi ultimi si limitano ad osservare il messicano (Paredes 1993). Così, se per un verso i messico-americani faticano a liberarsi da un’immagine negativa di sé interiorizzata a partire dal giudizio negativo anglo sugli ispanici, non esitano a reinterpretare gli stili americani amalgamandoli al proprio gusto: è il caso dei vestiti sgargianti chiamati zoot-suit o della ballata popolare che nell’elaborazione chicana diventa border corrido e conjunto, generi che evocano tradizioni musicali etniche messicane, e nello stesso tempo aprono alla transizione verso l’altro soggetto/l’altra cultura sul confine. A partire dal Teatro Campesino di Luis Valdéz, si è sviluppata una produzione nel campo delle arti con forti tracce di resistenza all’egemonia culturale angla, ma nello stesso tempo proprio il ricorso ai linguaggi culturali serve a rendere più praticabile il contatto, a trascendere cioè l’antagonismo e a portare insieme elementi di culture diverse per creare nuove modalità di esperienza creativa per entrambe le culture. Un argomento di grande rilievo negli studi di frontiera riguarda la messa in discussione dello stato-nazione di origine europea e quindi l’egemonia culturale del modello politico e sociale eurocentrico. Questo pensiero-pratica dell’attraversamento delle frontiere e di una posizionalità frontaliera ha praticamente invaso ogni ambito della vita e cultura chicana, inscrivendosi nelle diverse pratiche artistiche che divengono tutte border texts segnati da contaminazione di stili e discorsualità, ovvero testi interculturali che praticano l’attraversamento delle frontiere fra arti, generi e lingue. A partire dagli anni Ottanta, come è accaduto per tante frange dei movimenti radicali poi trasformatisi in studi – Studi (post-)coloniali, studi di donne, studi multiculturali, ecc. – anche il movimento chicano per i diritti civili ha partorito gli studi chicani, che oggi sono complessivamente chiamati Border studies, e ha incrociato gli studi femministi, che hanno mostrato come il patriarcato impastava e impasta d’universalismo, monologismo e oppressione tanto il mondo pre-colombiano che quello messicano e quello anglo. Fu sempre Anzaldúa, insieme a Chérrie Moraga ad aprire la riflessione femminista a problematiche razziali ed etnografiche col loro volume This Bridge Called My Back (1983), che diede voce a tutto il femminismo radicale colored degli Stati Uniti. In Terre di confine, Anzaldúa sessualizza i discorsi e chiama questa coscienza mestiza, conciencia de mujer, coscienza di donna (Anzaldúa 1987). Oltrepassare i confini o riattraversarli incessantemente diviene una pratica per ridefinire anche la propria identità sessuale oltre che quella psicologica e culturale. La mobilità della frontiera diviene paradigma di cambiamento e trasformazione: nominarsi new mestiza comporta un caminho, un processo di ridefinizione del sé e della cultura. Negli anni Novanta il discorso fu portato oltre attraverso le nuove riflessioni dei saggi, sempre a cura di Anzaldúa, intitolati Making Face, Making Soul/Haciendo Caras (1990), e recentemente è apparso, a cura di Anzaldúa e Analuise Keating, This Bridge We Call Home (2002) che fa il punto sulla teorizzazione multiculturale femminista, ma accoglie anche la voce di uomini che riflettono sulle questioni poste dalle autrici nel libro del 1983 e sul loro esito. Un riconoscimento vero alla cultura chicana giunse con la mostra itinerante chiamata, dal suo acronimo, cara (Chicano Art: Resistance and Affirmation 1965-1985), che fra il 1990 e il 1993 attraversò gli usa dal nord al sud, toccando città come Denver, Albuquerque, San Francisco, Washington, New York e San Antonio. Con questa mostra le porte della casa padrone ovvero gli spazi esclusivi dei grandi musei si aprirono e divennero ambienti di stile chicano, stanze in cui veniva promosso un dialogo e una riflessione interculturale (Gaspar de Alba 1997). Per gli artisti della raza, cara significò trovare per la prima volta casa in uno spazio pubblico non ghettizzato. cara mostrò come la cultura alter-nativa si autorappresentava, creava la propria faccia, dice Anzaldúa (Anzaldúa 1990; il termine spagnolo cara significa per l’appunto faccia). Creare il volto significa raffigurare, far vedere ma anche vedersi; può divenire gesto politico sovversivo: può essere sguardo penetrante che interroga e sfida, sguardo che dice “non camminarmi addosso”, ma anche “lascia stare la mia faccia” (Anzaldúa 1990, p. xv). Le scrittur-azioni di Anzaldúa, di Moraga e di altre scrittrici e la sezione delle installazioni del cara intitolate Visioni femministe hanno aiutato a decostruire l’immagine della donna chicana così come era costruita dentro le norme patriarcali della cultura chicana e perfino dentro il Chicano Art Movement: Con un gesto da border crossing le artiste rovesciano l’antitesi virgen/puta, incarnata nella scissione vergine di Guadalupe (sintesi dell’antica mitologia azteca e della religione cattolica, del divino e umano, mediatrice per tutti i mestizos) e la Malinche (chiamata anche con nome azteco Malintzin e in messicano spregiativamente Chingada), ovvero la prima donna india venduta a Hernan Cortes, colei che per prima imparò lo spagnolo e svolse funzioni di traduttrice, divenendo agli occhi del suo popolo icona della traditrice e della prostituta. Al posto di questo binarismo viene creata una figura-intersezione, simbolo di resistenza e intelligenza (voler conoscere la lingua altrui non è semplicemente tradimento, ma indice di apertura e curiosità) in cui corpo e anima, eros e spiritualità, terra d’origine e terra del conquistatore vengono presentati non come parti separate, ma impastate e tanto la vergine di Guadalupe come la Malinche sono raffigurate come figure ibridate, luoghi di traduzione culturale, ovvero di frontiera. Operazioni come quelle del cara, scritture alter-native come quelle di Anzaldúa o Sandra Cisneros, Ana Castillo, Tino Villanueva, Alfred Arteaga sono state uno strumento di concientización (acquisizione di consapevolezza) della gente chicana e di contestualizzazione della cultura di gente a discendenza messico-ispanico-indio con venature africane nella società americana nel suo complesso. Ponendo attenzione alle tensioni fra soggettività e rappresentazione, cultura alta e cultura popolare, presentando la cultura chicana come altra eppure indigena alla cultura americana, cara e tutti i soggetti che assumono consapevolmente una posizione frontaliera, mettono in discussione le strutture istituzionali, gli stili, i modelli che si fondano sull’esclusione, l’etnocentrismo e l’omogeneizzazione; mettono in crisi il mercato dell’arte tradizionale, la politica dell’autorappresentazione e la teoria-pratica della ricezione in quanto, confrontandosi con culture e comunità eterogenee, composite, salvano l’eredità multilinguistica e multiculturale condensata nei concetti di mestizaje e raza (Gaspar de Alba 1997) e resistono alla ideologia bianca americana del melting pot attraverso pratiche di resistenza come la coscienza oppositiva, e la metodologia degli oppressi (Sandoval 2000). La cultura del border crossing si esprime attraverso una commistione di stili e discorsi, attraverso una resistenza alla cultura alta e una predilezione per il vernacolo, il rasquache che si esprime attraverso l’eccesso, l’ironia, i colori brillanti, gli ornamenti scintillanti. Dentro i Chicano/cultural studies si possono quindi rinvenire discorsi cosiddetti contro-egemonici, anti-nativisti, anti-acculturazione che contestano la categorizzazione delle culture definite marginali in sotto-culture (scuola di Chicago, Landowki), ridotte a oggetto di scoperte, e svelano i presupposti gerarchici delle teorie che organizzando le culture in sotto-categorie, presuppongono una categoria di riferimento normante. Questa celebrazione-pratica dell’attraversamento, impollinazione, incrocio, commistione che si disvela nella mescolanza di discorsi locali e globali, nazionali e internazionali, tradizionali e sperimentali (per es. l’inclusione di proverbi e versi di ballate in letteratura; di stilemi degli ex-voto o retablo in pittura; di strumenti e ritmi tradizionali in musica contaminata), personali e politici, naïf e digitali, fa della frontiera una figurazione della modernità, una contronarrativa; e del border crossing una pratica sociale unica, un’estetica nuova, mestiza – non una sotto-cultura segregata dentro le maglie della cultura-sguardo egemonico, ma una co(n)-cultura o, per dirla con Gaspar de Alba, una alter-cultura, una cultura alter-nativa (dove alter sta per altro da sé, un’altra identità). Una cultura altra che tuttavia è nativa, specifica di quella geografia, il territorio del Sud-Ovest degli Stati Uniti un tempo vissuto come estensione della Spagna dall’impero spagnolo, poi chiamato Messico del nord, quindi Sud-Ovest americano (dagli Stati Uniti), e attualmente denominato dai chicanos patria chicana di Aztlán (Gaspar de Alba 1997). A partire dalle teorizzazioni e pratiche culturali nate sul confine fra Messico e Stati Uniti, i Border Studies sono saliti alla ribalta del discorso socioculturale, presentandosi come uno degli ambiti di riflessione più nuovi e complessi degli ultimi anni: quest’area creativa e teorica sta sul confine degli studi culturali, etnici, multiculturali, antropologici e si occupa di questioni contemporanee circa i saperi, l’identità e la politica. In ambito anglo-americano il grande impulso che viene dallo sviluppo di questo tipo di studi può oggi addirittura essere problematico in quanto tutte le discipline appaiono suscettibili di reinscrizione entro i Border studies: da quelle giuridiche a quelle politiche, a quelle identitarie (anche gli studi queer rientrano nelle teorizzazioni ed interpretazioni dei Border studies) e societarie.
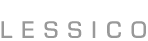
Affiliazioni transnazionali, Assimilazione, Bilinguismo, Border crossing, Border texts, Borderlands, Canone, cara (Chicano Art: Resistance and Affirmation), Centro, Chicanismo, Chicano studies, Cittadinanza, Classe, Contaminazione, Controcultura, Contronarrativa, Cultura alter-nativa, Culturale, Decolonizzazione, Egemonia culturale, Emigrazione, Esilio, Etnotesto, Frontalieri, Fronterizos, Frontiera, Gender Studies, Ibridismo, Identità, In-between, Intercultura, Interlinguismo, Letteratura popolare, Malinche, Melting pot, Mestizaje, Mestizos, Metodologie degli oppressi, Migrazione, Multiculturalismo, Multilinguismo, New mestiza, Occidentale, Orientamento sessuale, Passing, Musica popolare, Periferia, Politica della location, Primo mondo, Queer studies, Rasquachismo, Raza, Miscegenation, Strategie di resistenza, Subcultura, Terzo mondo, Terzo spazio, Transcultura, Vergine di Guadalupe, World music.

http://libraryweb.utep.edu/ref/border.html
http://orion.it.luc.edu/~pjay/border2.htm
http://www.humanities-interactive.org....exhibitindex.html
http://www-rohan.sdsu.edu/dept/mas/mas1.html

Anzaldúa, G., 1987, Borderlands /La Frontera, San Francisco, Aunt Lute; trad. it. 2000, Terre di confine/La frontera, Bari, Palomar.
Anzaldúa, G., 1990, Making Face, Making Soul/Haciendo Caras, San Francisco, Aunt Lute.
Anzaldúa, G., Keating, A., 2002, This Bridge We Call Home. Radical Visions for Transformation, London, Routledge.
Anzaldúa, G., Moraga, C., 1983, This Bridge Called My Back. Writings by Radical Women of Color, New York, Women of Color Press.
Aztlán: A Journal of Chicano Studies.
Bacchiega, F., a cura, 1990, Sotto il quinto sole. Antologia di poeti chicani, Firenze, Passigli.
Bhabha, Homi K., 1994, The Location of Culture, London, Routledge; trad. it. 2001, I luoghi della cultura, Roma, Meltemi.
Bottalico, M., 1979, Zoot Suit, fra compromesso e azione sociale, <<Sipario>>, XXXIV, p. 396.
Bottalico, M., 1979, Cultura di base e ricerca d'identità di una minoranza etnica americana; il Teatro campesino come teatro di comunità, <<Metaphorein>>, II, p. 6.
Bottalico, M., 1981, “La letteratura chicana”, in E. Zolla, a cura, Novecento americano, Roma, Lucarini, vol. III, pp. 695-709.
Bottalico, M., 1996, “Le 'forze' del mondo meticcio. Sulla trilogia di Rudolfo Anaya”, in E., Siciliani, a cura, America ieri e oggi, Fasano, Schena, pp. 191-223.
Bottalico, M., 1998, “Città nella città. Il barrio nella narrativa chicana fra realismo critico e realismo magico”, in C. Giorcelli, C. Cattarulla, A. Scacchi, a cura, Città reali e immaginarie del continente americano, Roma, Edizioni Associate, pp. 127-141.
Bottalico, M., 1999, Contro il silenzio. Geografia della memoria nella scrittura chicana. ‘The House of Mango Street e Madreselvas en Flor’, <<Letterature d’America>>, XVI, pp. 67-68.
Bruce-Novoa, J., 1990, RetroSpace. Collected Essays on Chicano Literature, Theory and History, Houston, Arte Público Press.
Calefato, P., Colaizzi G., Caprettini, G. P., a cura, 2001, Incontri di culture. La semiotica fra frontiere e traduzioni, Torino, Utet.
Chávez, J. R., 1984, The Lost Land. The Chicano Images of the Southwest, Albuquerque, University of New Mexico.
Corti, E., 1997, Chicanos, Mexican-Americans, Hispanics. Una questione d'identità, <<Ácoma>>, IV, p. 11.
De Chiara, M., 2001, La traccia dell'altra, Napoli, Liguori.
Fiske, J., 1989, Understanding Popular Culture, Boston, Unwin-Hyman.
Gaspar de Alba, A., 1997, Chicano Art Inside/Outside the Master House, Austin, University of Texas Press.
Gaspar de Alba, A., 2002, “Identità estetiche di Aztlán. Luogo e genere nell'arte del/la chicano/a”, in P., Zaccaria, a cura, Estetica e differenza, Bari, Palomar, pp. 221-240.
Gebbia, A., 1976, Chicanos! Cultura e politica dei messico-americani, Venezia, Marsilio.
Godayol, P., 2002, Spazi di frontiera. Genere e traduzione, Bari, Palomar.
Kaplan, C., Grewal, I., 1994, Scattered Hegemonies. Postmodernity and Transnational Feminist Practice, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Leon-Portilla, M., 1961, Los antiguos Mexicanos. Através de sus crónicas y cantares, Mexico, Fondo de Cultura Económica.
MacIel, D. R., Herrera-Sobek, M., 1998, Culture Across Borders. Mexican Immigration and Popular Culture, Tucson, University of Arizona Press.
Mesa-Bains, A., Ybarra-Frausto, T., 1988, Ceremony of Memory. Contemporary Hispanic Spiritual and Cerimonial Art, Santa Fe, Center for Contemporary Arts.
Paredes, A., 1993, Folklore and Culture on the Texas-Mexican Border, Austin, University of Texas Press.
Penalosa, F., 1980, Chicano Sociolinguistics. A Brief Introduction, Long Beach, California State University.
Saldivar, R., 2002, “Migrazioni transnazionali e identità di confine. Immigrazione e cultura postmoderna”, in P. Zaccaria, a cura, Estetica e differenza, Bari, Palomar, pp. 241-259.
Sandoval, C., 2000, The Methodology of the Oppressed, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Steiner, S., 1972, La Raza. I messicoamericani, Milano, Jaca Book.
Tessarolo Bondolfi, L., 1988, Dal mito al mito. La cultura di espressione chicana dal mito originario al mito rigeneratore, Milano, Jaca Book.
Vasconcelos, J., 1961, La raza cósmica. Míssion de la raza ibero-americana, México, Aguilar S. A. Ediciones.
Villanueva, T., 1978, Sobre el término 'chicano', <<Cuadernos Hispanoamericanos>>, n. 336, pp. 387-410.
Zaccaria, P., 1999, Mappe senza frontiere. Cartografie letterarie dal modernismo al transnazionalismo, Bari, Paolomar.
Zaccaria, P., 2001, “Vivir en la frontera”, in A. Ramirez, M. Arriaga, a cura, Representar-representarse. Firmado mujer, Huelva, Artes Graficas Giron, pp. 643-653.