La prima ondata di interesse per lo studio del corpo come fenomeno sociale, non più dipendente dalla tradizionale prospettiva filosofico-religiosa dell’antitesi corpo/anima, ma legato piuttosto ad una lettura antropologico-scientifica del problema in chiave popolare, ha forse investito l’Italia negli anni Settanta e Ottanta con i risultati delle riflessioni dell’Ècole des Annales francese. Ha poi mantenuto la propria forza propulsiva grazie all’intensa opera di traduzione e di ricezione degli studi di Michel Foucault, tra cui spiccano quello dedicato alla nascita della clinica e quella, assai ampia, sulla storia della sessualità.
Per una vivace ricognizione della storia del corpo nelle sue varie declinazioni metodologiche pare opportuno rinviare al saggio di Roy Porter, che nell’excursus presente nel volume New Perspectives on Historical Writing (1991) curato da Peter Burke, introduce ai più recenti e ai più diffusi metodi di indagine sul corpo affermando la necessità di non disgiungere mai la storia biologica del corpo dalle considerazioni culturali che lo riguardano. Questa urgenza si mostra con particolare evidenza, tra l’altro, nel lavoro degli storici della medicina come Porter, qualora la ricognizione che pone in relazione il corpo del malato con le strutture sanitarie non metta troppo in ombra considerazioni generali di carattere antropologico e culturale, più urgenti nel contesto della storia delle mentalità.
La diffusione delle rappresentazioni del corpo in discorso, laddove esso assuma una valenza testuale, dipende dall’affermarsi di tecniche poststrutturaliste e decostruzioniste di analisi, verificabili sulla scorta del lavoro di Roland Barthes, Le Plaisir du Texte (1973). Come ha scritto Alessandra Violi, Barthes “pur sostituendo il piacere della profondità con il godimento della pluralità eterogenea di superficie del corpo/testo testimonia comunque l’incidenza metaforico-conoscitiva del corpo leggibile fisiognomico sull’estetica e sulla retorica della modernità” (Violi 1998, p. 63). Nello studio della Violi, che si muove specialmente sul terreno delle ricerche di area anglo-americana e francese relative al corpo anatomizzato tra pratiche mediche e osservazioni dissettive interne al testo, troviamo tra l’altro preziosi spunti bibliografici relativi a questo percorso, che in parte rinviano anche ai suggerimenti di lettura di Porter. Spicca tra gli altri il saggio di Jonathan Sawday, The Body Emblazoned: Dissection and the Human Body in Renaissance Culture (1995) a cui si può accostare, per la parte storico scientifica della più stretta ricognizione sul Rinascimento, il testo di Andrea Carlino, La fabbrica del corpo. Libri e dissezione nel Rinascimento (1994). La lettura multiprospettica del problema corpo, comprensiva di vari ambiti del sapere e di uno sforzo di collegamento interdisciplinare tra gli argomenti è certamente più praticabile se effettuata in seno a un percorso organico, piuttosto che pretestuosamente, laddove la problematica del corpo venga considerata un serbatoio ideale in cui è possibile versare una molteplicità di esperienze specialistiche che non trovano aggancio l’una all’altra. Molto più interessante pare allora la proposta del lavoro a più mani pubblicato in Germania con il titolo Transfigurationen des Körpers. Spuren der Gewalt in der Geschichte (1989) da Dietmar Kamper e Christoph Wulf che propone due sezioni, di cui la prima, intitolata Schnittmuster (letteralmente modelli di taglio), si riferisce soprattutto alla semiotica del corpo nella tradizione che va dal mito della Grecia classica alla fine del Settecento, la seconda, intitolata Vexierbilder (rebus, letteralmente immagini a sorpresa) lascia spazio a interpretazioni di specifiche opere letterarie o artistiche o di attitudini comportamentali – come la libidine (Geilheit) – tra rappresentazione (Vorstellung) e presentazione (Darstellung).
Il corpo non è solo il luogo della violenza subita o provocata, ma anche il luogo della differenza e della discriminazione tra i sessi, un tema sul quale si incontrano gli studi culturali e studi più specificamente rivolti alla questione di gender in senso socio-politico. Molto illuminante è in questo senso il lavoro di Thomas Laqueur che prende in esame la resistenza del pensiero femminista di fronte alla distinzione fra sesso e genere e cita la prospettiva di Catherine Mac Kinnon e di Ruth Bleier, in quanto entrambe vedrebbero in essa una strategia guidata dalla sfera di potere maschile per tenere separate la differenza biologica e il ruolo sociale (Laqueur 1990). Il genere, al contrario, deve coinvolgere biologia e società, cosicché la differenza sia verificabile a livello puramente comportamentale e risulti irrilevante in senso biochimico. Porter suggerisce che dal discorso sul sesso ci si sposti a quello sulla sessualità, se si vuole spiegare come sulla base di un nuovo immaginario femminile legato al sesso e al ruolo, in quanto fondato su un secolo di esperienze sociali, Freud sia riuscito a razionalizzare i conflitti tra i due sessi, ipotizzando delle vie d’uscita alle nevrosi comportamentali. Judith Butler discute invece la prospettiva eterosessuale, che condizionerebbe il giudizio rispetto a ciò che deve essere considerato normale e naturale e a ciò che fa parte della sfera dell’abbietto. Questa codificazione produrrebbe un’alterità emarginata, che ha però la possibilità di risignificarsi in modo imprevisto nel contesto di una realtà che conglomera etnie diverse, secondo un assetto più dinamico delle identità.
Se un’analisi del corpo sofferente, come si diceva prima, insiste su una contestualizzazione specifica della fisicità in ambito sociale, essa può essere comunque spesa per un discorso politico sul corpo umiliato dalla tortura o dalla guerra. Il corpo si estende così sul mondo circostante, trasformandolo in protesi del sentire doloroso. Questo è il tema di The Body in Pain. The Making and Unmaking of the World (Scarry 1985). Non solo è in causa, qui, la proiezione immaginaria dell’Io sul mondo esterno, ma una vera e propria relativizzazione del contesto vitale rispetto all’Io. Mentre la Scarry non approfondisce questioni di isofunzionalismo legate alla tecnologia, è invece completamente dedicato al remapping sensoriale, cioè alla riconfigurazione del corpo su base artificiale, il libro curato da Pier Luigi Capucci, Il corpo tecnologico. L’influenza delle tecnologie sul corpo e sulle sue facoltà (1994). All’inquietante diagnosi di Stelarc, nel saggio contenuto nel volume di Capucci, Da strategie psicologiche a cyberstrategie: prostetica, robotica ed esistenza remota, secondo cui il corpo umano sarebbe ormai obsoleto e il rapporto che interessa in modo centrale la società non è tanto quello tra uomo e donna, quanto quello tra uomo e macchina, si può rispondere con l’auspicio di Mariella Combi che si operi un radicale recupero del nostro corpo e del nostro sentire per mezzo di un più serio scandaglio delle emozioni, sperimentando cioè il corpo dall’interno e rispondendo ai suoi bisogni.
Sostare sul saggio di Franco Rella, Ai confini del corpo (2000) è forse il modo migliore per concludere che il corpo non costituisce semplicemente il pretesto, ma piuttosto il pre-testo per escursioni illimitate tra i campi del sapere, pur obbligando al paradossale confronto, inesorabile e continuo, con la sua finitezza. Basti pensare all’esperienza figurale artistica che si alimenta della forma corporea fin dalle origini e continua a manipolarla, deformarla e trasfigurarla fino a dissolverla nell’astrazione, per poi ritornare, nel presente, a decise proposte materiche. Questa esperienza richiederebbe un’indagine separata per quanto riguarda le recenti ricognizioni sul soggetto corporeo, che in questo contesto non è possibile condurre.
Il corpo ha smesso di essere nemico del sapere, in età moderna, cioè di costituire l’antitesi della psiche intesa sia come anima che come mente. Forti in una recensione dell’acclamato studio di Adriana Cavarero, Corpo in figure. Filosofia e politica della corporeità, osserva che si va sempre più affermando in Italia quella corrente del pensiero contemporaneo impegnata nella paradossale arte di far parlare ciò che la tradizione metafisica e logocentrica avrebbe, invece, messo a tacere (Forti 1996). La teoria della Cavarero, per la quale la politica sarebbe stata considerata fin dall’antichità nemica del corpo, soprattutto di quello femminile, non sfocia nell’attesa apologia di un presente più generoso nei confronti della carne e dei suoi bisogni, ma in una trasognata lettura della figura di Antigone, creata dalla penna di Maria Zambrano, e di quella di Ondina, intensamente ritratta da Ingeborg Bachmann.
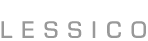
Body piercing, Corpo, Corporeità, Embodiment, Tatuaggio, Virtual.

http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=359
http://www.cddc.vt.edu/feminism/bod.html
http://www.evoyage.com/BooksBySubject/FemaleBodyStudies.htm

Barthes, R., 1973, Le plaisir du texte, Paris, Seuil; trad. it. 1999, Variazioni sulla scrittura seguite da Il piacere del testo, Torino, Einaudi.
Bleier R., 1984, Science and the Gender. A Critique of Biology and its Theories on Woman, New York, Pergamon Press.
Burke, P., 1991, New Perspectives on Historical Writing, Cambridge, Cambridge UP; trad. it. 2000, La storiografia contemporanea, Roma-Bari, Laterza.
Butler, J., 1993, Bodies that matter. On the Discursive Limits of ‘Sex’, London, Routledge; trad. it. 1996, Corpi che contano, Milano, Feltrinelli.
Capucci, P. L., 1994, Il corpo tecnologico. L’influenza delle tecnologie sul corpo e sulle sue facoltà, Bologna, Baskerville.
Carlino, A., 1994, La fabbrica del corpo. Libri e dissezione nel Rinascimento, Torino, Einaudi.
Cavarero, A., 1995, Corpo in figure. Filosofia e politica della corporeità, Milano, Feltrinelli.
Combi, M., 1998, Il grido e la carezza. Percorsi nell’immaginario del corpo e della parola, Roma, Meltemi.
Forti, S., 1996, Corpo in figure. Filosofia e politica della corporeità, <<L’Indice>>, n. 9.
Foucault, M., 1963, Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical, Paris; trad. it. 1969, Nascita della clinica, Una archeologia dello sguardo medico, Torino, Einaudi.
Foucault, M., 1976, Histoire de la sexualité, Paris, Gallimard; trad. it. 1978, Storia della sessualità, Milano, Feltrinelli.
Kamper, D., Wulf, Ch., 1989, Transfigurationen des Körpers. Spuren der Gewalt in der Geschichte, Berlin, Reimer.
Laqueur, Th., 1990, Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, Harvard, Harvard UP.
Mac Kinnon, C., 1989, Toward a Feminist Theory of the State, Cambridge, Harvard UP.
Pancino, C., 2000, Corpi. Storia, metafore, rappresentazioni fra Medioevo ed età contemporanea, Venezia, Marsilio.
Rella, F., 2000, Ai confini del corpo, Milano, Feltrinelli.
Sawday, J., 1995, The Body Emblazoned. Dissection and the Human Body in Renaissance Culture, London, Routledge.
Scarry, E., 1985, The Body in Pain. The Making and Unmaking of the World, Oxford, Oxford UP; trad. it. 1990, La sofferenza del corpo. La distruzione e la costruzione del mondo, Bologna, il Mulino.
Violi, A., 1998, Le cicatrici del testo. L’immaginario anatomico nelle rappresentazioni della modernità, Bergamo, Sestante.
Violi, A., 2002, Il teatro dei nervi. L’immaginario nevrosico nella cultura dell’Ottocento, Bergamo, Sestante.