La paura dello straniero e la sua esclusione da parte di qualsiasi gruppo omogeneo richiamano un comportamento originario degli uomini come degli animali. L’interesse scientifico degli antropologi, etologi e sociologi verso questo fenomeno è comunemente indicato col termine xenologia. Qui si farà riferimento principalmente ad alcuni studi a cavallo fra la sociologia e le scienze letterarie, con particolare riguardo all’ambiente tedesco e alle espressioni letterarie rappresentate soprattutto in poesie, romanzi e in testi autobiografici scritti dagli immigrati stranieri, siano essi europei o extraeuropei.
Georg Simmel ha considerato l’interazione tra vicinanza e lontananza e la posizione oggettivante del forestiero in un excursus sullo straniero nel testo Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung (1908). La traduzione del suo allievo Albion Small, The Stranger (1928), è diventato un testo epistemologico alla base di tanti studi sociologici americani attorno alla problematica del forestiero, degli immigrati e dell’etnicità.
Il rapporto fra indigeni e stranieri, condizionato dalla quasi innata paura e conseguentemente dal rifiuto ostile dell’altro, è però anche caratterizzato da sentimenti di curiosità e di attrazione, anche sessuale, verso il nuovo e l’esotico propri degli immigrati. A ciò corrisponde, dall’altra parte, il bagaglio culturale, lo spirito pionieristico e la spinta innovativa di quelli che vengono da lontano. Il loro status di minoranza e di dipendenza economica che necessita dell’ospitalità crea regolarmente un rapporto d’inferiorità che alimenta tanti pregiudizi e stereotipi. Alla luce di questo complesso rapporto di reciprocità la xenologia si rivela essere sempre anche una indigenologia.
La storia della convivenza fra popolazioni radicate nella loro terra e i loro ospiti, siano singoli viaggiatori o vari gruppi migratori, è stata studiata nel suo riflesso culturale e psicologico, con particolare attenzione agli ideali cosmopolitici dell’Illuminismo, da Julia Kristeva in Étrangers à nous mêmes (1988). Un panorama più completo è presente nel testo di Alexander Demandt, Mit Fremden leben. Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart (1995). Bedrich Loewenstein presenta un profilo storico ed etologico, cui seguono alcune analisi della situazione degli stranieri nelle città-stato della Grecia antica, nei regni persiano, bizantino e romano, sotto il dominio islamico e nelle città medievali, degli ugonotti in Prussia e anche degli emigranti tedeschi negli usa e nell’America latina, infine degli ebrei fuggiti dai pogrom nell’Europa orientale verso la Germania e la Gran Bretagna nel tardo Ottocento (Loewenstein 1990). La funzione dei forestieri come mediatori e stimolatori nei processi civilizzatori è il tema di un saggio di Robert Hettlage Der Fremde. Kulturvermittler, Kulturbringer, Herausforderer von Kultur (1987).
Anche alcuni studiosi italiani si sono occupati dell’eco letteraria dei fenomeni migratori come documentano i lavori di Lina Grossi e Rosa Rossi (1997) e di Mario Domenichelli e Pino Fasano (1997) esplicitamente dedicati allo straniero. Gli aspetti problematici inerenti ad ogni incontro fra rappresentanti di civiltà diverse vengono invece illustrati da Umberto Melotti e Alois Wierlacher. Nell’esaustiva introduzione al fondamentale volume Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung (1993); Wierlacher dedica particolare attenzione anche al sempre troppo poco rispettato ideale della tolleranza. Yoshiro Nakamura nel suo Xenosophie. Bausteine für eine Theorie der Fremdheit (2000) tenta infine una sistemazione teorica complessiva del molteplice campo di studi.
Il forestiero è una figura frequente nella letteratura a cominciare dall’Ulisse di Omero. Particolarmente note sono le rappresentazioni dell’ebreo, del moro, o del selvaggio nel teatro elisabettiano, studiati ad esempio da Leslie Aaron Fiedler (1960). Ma in questa sede il tema o le figure tradizionali interessano meno della letteratura scritta dai migranti stessi e in particolar modo dei testi scritti non nella loro madrelingua ma in quella del paese che li ospita e dove sviluppano una nuova maniera di scrittura e spesso addirittura un nuovo linguaggio poetico. Le scienze sociali si interessano a questi testi come a documenti dello status sociale, culturale e psicologico degli stranieri. La critica letteraria si occupa invece delle nuove forme d’espressione estetica e dei fenomeni linguistici. La complessità del capire l’altro, con riferimento sia al fenomeno dell’estraneità sia all’espressione di una letteratura venuta da fuori, viene illustrato nel volume a cura di Ernest Hess-Lüttich ed altri dal titolo Fremdverstehen in Sprache, Literatur und Medien (1996). La globalità del fenomeno è stato anche l’oggetto dell’ottavo congresso internazionale dei germanisti Begegnung mit dem ‘Fremden’. Grenzen, Traditionen, Vergleiche (1990), i cui atti comprendono anche il volume a cura di Yoshimori Shichiji Emigranten und Immigrantenliteratur (1991).
Il poliglottismo degli autori stranieri, ospiti per sempre in un paese che considerano la loro seconda patria, è l’argomento di Simone Hein-Khatib in Sprachmigration und literarische Kreativität (1998). La funzione degli stereotipi sulla percezione dell’altro, combinando i metodi della psicologia sociale e dell’analisi dei testi letterari, è analizzata da Elisabetta Mazza Moneta in Deutsche und Italiener. Der Einfluß von Stereotypen auf interkulturelle Kommunikation. Deutsche und italienische Selbst- und Fremdbilder und ihre Wirkung auf die Wahrnehmung von Italienern in Deutschland (2000).
Il linguaggio poetico è al centro dell’attenzione dei germanisti e degli scrittori stessi nella maggior parte dei contributi raccolti nei volumi curati da Caroline Lüderssen e Salvatore Sanna (1995), Pasquale Gallo (1998) e Giovanni Scimonello (1998).
Negli studi di stampo germanistico, menzionati finora, prevale la prospettiva del paese ospitante. La prospettiva del paese mandante è invece presentata da Jean-Jacques Marchand ne La letteratura dell’emigrazione. Gli scrittori di lingua italiana nel mondo (1991) e nel saggio La letteratura dell’immigrazione italiana in Svizzera (1991). Tali studi iniziarono con i saggi degli autori emigrati già negli anni Settanta e Ottanta, tra i quali si ricorda Franco Biondi (1984). La prospettiva si estende poi alla letteratura scritta in tedesco da autori provenienti da altri paesi, soprattutto dalla Turchia e dai paesi arabi, nei libri di Immacolata Amodeo (1996) e di Carmine Chiellino (1995). Recentemente Chiellino ha raccolto i frutti di tali studi nel primo manuale, Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch (2000).
Negli studi (post)coloniali il concetto di ibridismo è stato trapiantato dal campo biologico a quello culturale e letterario. La lingua italiana segnala un significato per estensione dell’aggettivo ibrido: “composto da individui provenienti da regioni o nazioni diverse; privo di unità etnica”, e un altro linguistico: “che è composto di elementi che derivano da lingue diverse” (Battaglia, Grande Dizionario della Lingua Italiana). I due significati caratterizzano la nuova letteratura nata dalle circostanze sociali dei migranti che arricchiscono la lingua e la letteratura dei paesi ospitanti con interessanti effetti di straniamento. Un quadro culturale e sociologico di questi processi in tante regioni europee è stato messo insieme da Valeria Heuberger in Das Bild vom Anderen. Identitäten, Mentalitäten, Mythen und Stereotypen in multiethnischen europäischen Regionen (1999). In Kulturelle Hybridität, Hiltrud Arens presenta infine quattro autori, il siriano Rafik Schami, l’iraniana Torkan, il turco Sinasi Dikmen e Libuse Monikova di Praga, che sono esemplari per l’espressione letteraria interculturale (Arens 2000).
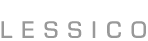
Carattere nazionale, Cliché, Das Eigene/das Fremde, Eterostereotipo, Fremdheit, Habitus, Identità, iik Bayreuth (Institut für Internationale Kommunikation und Auswärtige Kulturarbeit), Imago, Immagine, Interculturalità, Interkulturelle lebensläufe (Identità Transnazionali), Nazionalismo, Psicologia dei popoli, Razzismo, Stereotipi, Stereotipo, Volksgeist.

http://www.iik-bayreuth.de

Amodeo, I., 1996, ‘Die Heimat heißt Babylon’. Zur Literatur ausländischer Autoren in der Bundesrepublik Deutschland, Opladen, Westdeutscher Verlag.
Arens, H., a cura, 2000, ‘Kulturelle Hybridität’ in der deutschen Minoritätenliteratur der achtziger Jahre, Tübingen, Stauffenburg.
Biondi, F., 1984, Von den Tränen zu den Bürgerrechten. Ein Einblick, in die italienische Emigrantenliteratur, <<Linguistik und Literaturwissenschaft>>, n. 56, pp. 75-100.
Chiellino, C., 1995, Am Ufer der Fremde. Literatur und Arbeitsmigration 1870-1991, Stuttgart, Metzler.
Chiellino, C., 2000, Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch, Stuttgart, Metzler.
Demandt, A., 1995, Mit Fremden leben. Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart, München, Beck.
Domenichelli, M., Fasano, P., a cura, 1997, Lo straniero. Atti del Convegno di studi di Cagliari, 1994, Roma, Bulzoni.
Fiedler, L. A., 1960, The Stranger in Shakespeare, New York, Macmillan; trad. it. 1979, Lo straniero in Shakespeare, Urbino, Argalìa.
Gallo, P., 1998, Die Fremde. Forme d’interculturalità nella letteratura tedesca contemporanea, Fasano, Schena.
Grossi, L., Rossi, R., 1997, Lo straniero. Letteratura e intercultura, Roma, Edizioni Lavoro.
Hein-Khatib, S., 1998, Sprachmigration und literarische Kreativität. Erfahrungen mehrsprachiger Schriftstellerinnen und Schriftsteller bei ihren sprachlichen Grenzüberschreitungen, Frankfurt a. M., Lang.
Hess-Lüttich, E., 1996, Fremdverstehen in Sprache, Literatur und Medien, Frankfurt a. M., Lang.
Hettlage, R., 1987, Der Fremde. ‘Kulturmittler, Kulturbringer, Herausforderer von Kultur’, in W., Lipp, a cura, Kulturtypen, Kulturcharaktere. Träger, Mittler und Stifter von Kultur, Berlin, Reimer, pp. 25-44.
Heuberger, V., Suppan, A., Vyslonzil E., 1999, Das Bild vom Anderen. Identitäten, Mentalitäten, Mythen und Stereotypen in multiethnische europäischen Regionen, Frankfurt a. M., Lang.
Iwasaki, E., a cura, 1990, Begegnung mit dem ‘Fremden’. Grenzen, Traditionen, Vergleiche, München, Iudicium Verlag.
Kristeva, J., 1988, Étrangers à nous mêmes, Paris, Fayard; trad. it. 1990, Stranieri a se stessi, Milano, Feltrinelli.
Loewenstein, B., 1990, Der Entwurf der Moderne. Vom Geist der burgerlichen Gesellschaft und Zivilisation, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Loycke, A., 1992, Der Gast der bleibt. Dimensionen von Georg Simmels Analyse des Fremdseins, Frankfurt a. M., Campus.
Lüderssen, C., Sanna, S., 1995, Letteratura de-centrata. Italienische Autorinnen und Autoren in Deutschland, Frankfurt a. M., Campus.
Marchand, J.-J., 1991, “La letteratura dell’immigrazione italiana in Svizzera”, in I. Baldelli, a cura, Lingua e letteratura italiana nel mondo oggi, Firenze, Olschki, pp. 457-479.
Marchand, J.-J., 1991, La letteratura dell’emigrazione. Gli scrittori di lingua italiana nel mondo, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli.
Mazza Moneta, E., 2000, Deutsche und Italiener. Der Einfluß von Stereotypen auf interkulturelle Kommunikation. Deutsche und italienische Selbst- und Fremdbilder und ihre Wirkung auf die Wahrnehmung von Italienern in Deutschland, Frankfurt a. M., Lang.
Melotti, U., 1993, “Xenofobia e razzismo. Concetti, dati, analisi”, in S. Giudro, a cura, Xenofobia. Fratelli da odiare, Napoli, Guida, pp. 101-139.
Nakamura, Y., 2000, Xenosophie. Bausteine für eine Theorie der Fremdheit, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Scimonello, G., a cura, 1998, Letteratura e immigrazione, <<Cultura tedesca>> n. 10, pp. 7-86.
Shichiji, Y., 1991, Emigranten- und Immigrantenliteratur, München, ludicium Verlag.
Simmel, G., 1908, Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Frankfurt a. M., Suhrkamp.
Wierlacher, A., 1993, “Kulturwissenschaftliche Xenologie”, in Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung. Mit einer Forschungsbibliographie, München, ludicium Verlag, pp. 19-112.